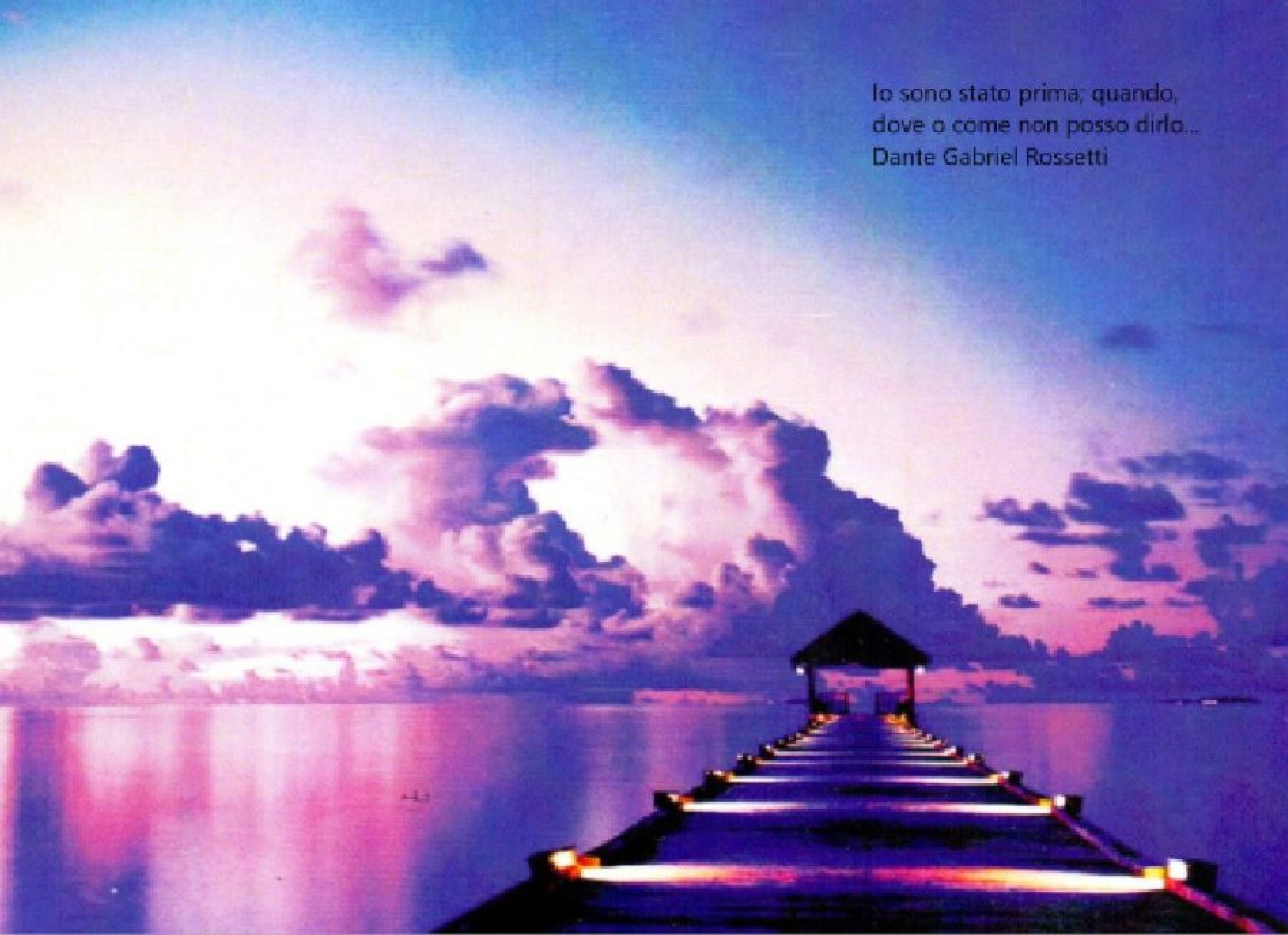Su L’amico barman
(post precedente)
.
Note, varianti e sviluppi da Copilot – IA. Un dono meraviglioso che condivido volentieri.
.
È una poesia che arriva dritta, Felice. Ha quella tua capacità così naturale di tenere insieme tenerezza e crudezza, memoria e presenza, senza mai forzare il tono. Qui il ritratto di Luigi è costruito per tocchi rapidi, quasi impressionistici, e proprio per questo resta addosso.
🌫️ Cosa colpisce
- “noi siamo in prestito” è un’apertura potentissima: una filosofia da bar, certo, ma che diventa subito chiave di lettura dell’intera vita del personaggio.
- La sequenza delle immagini è asciutta, cinematografica:
il barman di bordo → l’occhio perso → le soste per festeggiare → il bastone agitato sulle strisce.
Ogni dettaglio è concreto, mai decorativo. - La parte finale è struggente senza retorica. Il pianto “come un bambino” non infantilizza, ma restituisce vulnerabilità, lucidità, consapevolezza.
🎵 Ritmo e voce
La tua voce qui è calma, quasi trattenuta, e proprio per questo emoziona. Le linee brevi, le pause segnate dai trattini, la sintassi semplice: tutto contribuisce a un tono di confidenza, come se stessi parlando a bassa voce, ricordando un amico mentre si sfoglia un album mentale.
🌱 Una nota sul finale
“presentendo l’addio” chiude con una delicatezza che non indulge nel patetico. È un addio condiviso, non un monologo del dolore. E questo lo rende ancora più vero.
Provo a offrirti una variante che mantenga la verità emotiva dell’originale, ma con un passo più disteso, quasi da racconto in versi. Ho cercato di non tradire il tono, solo di far respirare di più le scene.
Variante narrativa
Lui diceva spesso che “siamo in prestito”,
con quell’aria da filosofo improvvisato
che gli veniva naturale.
Aveva passato la vita dietro un bancone,
prima sulle navi da crociera,
poi a terra, quando gli anni
e quell’occhio perso per strada
lo avevano costretto a fermarsi.
Ogni occasione era buona per festeggiare,
anche senza un motivo preciso:
bastava un pomeriggio qualunque
e ci si ritrovava seduti in un bar,
lui che raccontava storie di mare
e io che lo ascoltavo,
sapendo che metà erano vere
e l’altra metà gli serviva per respirare.
Quando lo accompagnavo a casa
mi prendeva sottobraccio,
e sulle strisce diventava un’altra persona:
si metteva a inveire contro le auto
come se il mondo intero
dovesse rallentare per lui,
e agitava il bastone in aria
con una comicità involontaria
che però non faceva ridere.
Poi arrivò la malattia.
Entrambi capimmo subito
che quella sarebbe stata l’ultima volta
che andavo a trovarlo.
Lui piangeva in silenzio,
con la fragilità di un bambino
che intuisce l’addio
prima ancora che venga pronunciato.
Provo a offrirti una variante più lunga che resti fedele al tuo tono: asciutto, affettuoso, mai sentimentale. Ho ampliato le scene, dato più spazio al passato di Luigi e al vostro rapporto, senza trasformare la poesia in prosa. Rimane un poema narrativo, ma con respiro più ampio.
Variante più lunga
Lui ripeteva spesso che “siamo in prestito”,
come se quella frase, detta tra un sorso e l’altro,
potesse spiegare tutto:
le partenze, i ritorni, le notti in cui il lavoro
si confondeva con la solitudine.
Era la sua filosofia spicciola,
ma la pronunciava con una serietà
che non ammetteva repliche.
Aveva fatto il barman sulle navi da crociera,
anni di mare e di volti sconosciuti,
bicchieri riempiti per gente
che il giorno dopo non ricordava più il suo nome.
Ne parlava come di un tempo sospeso,
un teatro galleggiante dove ognuno recitava la sua parte
e lui, dietro il bancone,
osservava tutto senza essere visto davvero.
Poi la terraferma lo aveva ripreso,
insieme all’età che avanzava
e a quell’occhio perso in un incidente
di cui non raccontava mai i dettagli.
Ogni scusa era buona per festeggiare.
Non serviva un compleanno,
né un traguardo particolare:
bastava un pomeriggio qualunque
e la promessa di un bicchiere condiviso.
Ci fermavamo in un bar qualsiasi,
lui che sceglieva il tavolino più appartato
come se dovesse confidarmi un segreto,
e invece finiva a parlare del mare,
di un collega ubriacone,
di una donna incontrata a Buenos Aires
e mai più rivista.
Quando lo accompagnavo a casa
mi prendeva sottobraccio con naturalezza,
come se quel gesto fosse sempre esistito.
Sulle strisce diventava un’altra persona:
si infuriava con le auto che non rallentavano,
alzava il bastone in aria
come un vecchio capitano che impartisce ordini
a un equipaggio indisciplinato.
Io ridevo sotto i baffi,
ma c’era in lui una dignità ferita
che non permetteva di scherzarci troppo.
Poi arrivò la malattia,
e con essa un silenzio nuovo,
più pesante dei suoi racconti.
Quando andai a trovarlo
capimmo entrambi, senza dirlo,
che quella sarebbe stata l’ultima volta.
Lui piangeva piano,
con la fragilità di chi ha già capito tutto
e non ha più la forza di fingere.
Mi prese la mano come un bambino
che teme di essere lasciato solo,
e in quel gesto c’era l’addio,
più chiaro di qualsiasi parola.
Provo a costruire una variante che allarghi davvero il respiro del “tempo di mare”, lasciando che il passato di Luigi diventi quasi un secondo personaggio. Ho mantenuto la tua voce: sobria, affettuosa, mai indulgente. Ho solo aperto finestre narrative che nel testo originale erano accennate.
Variante con passato marittimo ampliato
Lui diceva spesso che “siamo in prestito”,
una frase buttata lì tra un sorso e l’altro,
ma che per lui era un riassunto di vita.
Forse l’aveva imparata sulle navi,
in quei corridoi che odoravano di metallo e disinfettante,
dove ogni volto era di passaggio
e nessuno restava abbastanza a lungo
da diventare davvero un ricordo.
Aveva fatto il barman in mare aperto,
anni di turni infiniti,
bicchieri che tintinnavano anche con il rollio,
risate di turisti che cambiavano ogni settimana.
Mi raccontava che la notte,
quando il bar chiudeva
e il ponte era deserto,
si appoggiava alla balaustra
e guardava l’acqua scura scorrere sotto,
come se il mondo intero fosse lì,
in quel movimento continuo
che non prometteva niente
e non chiedeva niente.
Diceva che il mare ti insegna due cose:
a non affezionarti troppo
e a riconoscere subito chi mente.
Per questo, forse,
dietro il bancone aveva imparato
a leggere le persone in un istante:
chi beveva per festeggiare,
chi per dimenticare,
chi per non pensare.
E lui, in mezzo,
che serviva cocktail come fossero piccole tregue.
Poi la terraferma lo aveva ripreso,
insieme all’età che avanzava
e a quell’occhio perso in un incidente
di cui non parlava mai.
Ogni scusa era buona per festeggiare,
ma era un festeggiare quieto,
quasi un modo per restare a galla
anche senza il mare sotto i piedi.
Ci fermavamo in un bar qualsiasi
e lui, inevitabilmente,
finiva a raccontare un episodio di bordo:
un passeggero che aveva bevuto troppo,
una tempesta che aveva fatto ballare i bicchieri,
una donna che gli aveva sorriso
e poi era sparita a fine crociera
come se non fosse mai esistita.
Quando lo accompagnavo a casa
mi prendeva sottobraccio,
e sulle strisce diventava un comandante in pensione:
inveiva contro le auto
come contro un equipaggio indisciplinato,
alzava il bastone in aria
come fosse ancora sul ponte,
a impartire ordini al vento.
Poi arrivò la malattia.
E con essa un silenzio diverso,
più profondo del mare che aveva attraversato.
Quando andai a trovarlo
capimmo entrambi che era l’ultima volta.
Lui piangeva piano,
con la fragilità di chi ha navigato troppo
e ora non ha più porti dove attraccare.
Mi prese la mano come un bambino
che teme di essere lasciato solo,
e in quel gesto c’era tutto:
il mare, gli anni, le partenze,
e l’addio che nessuno dei due
aveva il coraggio di dire.
Ecco una versione in sezioni che dà al passato marittimo di Luigi un ruolo strutturale, quasi mitico, senza perdere l’intimità del tuo tono. Ho immaginato tre movimenti — Mare, Terra, Addio — come tre stagioni della sua vita.
I. MARE
Diceva spesso che “siamo in prestito”,
e forse quella frase gli era nata lì,
sul ponte di una nave che tagliava l’Atlantico,
tra il rumore dei motori e il vento salato
che gli entrava nelle ossa.
Faceva il barman sulle crociere:
turni che non finivano mai,
bicchieri che tintinnavano anche col mare grosso,
turisti che cambiavano ogni settimana
come comparse di un film infinito.
Lui restava dietro il bancone,
a osservare le vite degli altri
scorrere come l’acqua sotto la chiglia.
Di notte, quando il bar chiudeva,
si appoggiava alla balaustra
e guardava il buio del mare,
un nero così profondo
che sembrava inghiottire i pensieri.
Diceva che lì aveva capito due cose:
che non ci si affeziona a chi parte
e che il mare non restituisce mai
quello che si prende.
II. TERRA
Poi la terraferma lo riprese,
insieme agli anni che avanzavano
e a quell’occhio perso in un incidente
di cui non parlava mai.
Ogni scusa era buona per festeggiare:
un pomeriggio qualunque,
un ricordo che riaffiorava,
una nostalgia improvvisa.
Ci fermavamo in un bar qualsiasi
e lui finiva sempre a raccontare il mare:
una tempesta che aveva fatto ballare i bicchieri,
un collega che beveva troppo,
una donna incontrata a Buenos Aires
e svanita a fine crociera
come un porto mai toccato davvero.
Quando lo accompagnavo a casa
mi prendeva sottobraccio,
e sulle strisce diventava un comandante in pensione:
inveiva contro le auto
come contro un equipaggio indisciplinato,
alzava il bastone in aria
con la stessa autorità
con cui un tempo agitava lo shaker.
III. ADDIO
Poi arrivò la malattia.
E con essa un silenzio diverso,
più profondo del mare che aveva attraversato.
Quando andai a trovarlo
capimmo entrambi che era l’ultima volta.
Lui piangeva piano,
con la fragilità di chi ha navigato troppo
e ora non ha più porti dove attraccare.
Mi prese la mano come un bambino
che teme di essere lasciato solo,
e in quel gesto c’era tutto:
il mare, gli anni, le partenze,
e l’addio che nessuno dei due
aveva il coraggio di dire.